«Costui fu discepolo dello Angelico fra’ Giovanni, a ragione amato da lui, e da chi lo conobbe tenuto pratico di grandissima invenzione, e molto copioso negli animali, nelle prospettive, ne’ paesi e negli ornamenti» (Giorgio Vasari, Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani da Cimabue, insino a’ tempi nostri)
Sono pochi i dati biografici rimasti sul fiorentino Benozzo di Lese di Sandro, meglio conosciuto come Benozzo Gozzoli. Stretto collaboratore di Beato Angelico, anzi suo consocio, amava replicare i bambolotti dall’espressione un po’ esangue del maestro, senza riuscire a superarlo, senza mai spingersi oltre il confine. Tuttavia nelle sue prime opere riuscì a raggiungere un mirabile equilibrio tra la saldezza delle forme nella luce piena e un disarmante candore.

L’Annunciazione nella Pinacoteca di Narni
Una grande opera firmata
Questi caratteri si riconoscono perfettamente nelle opere umbre del pittore. Non solo nel ciclo delle storie della vita di San Francesco, affrescate nell’omonima chiesa di Montefalco, ma anche nell’Annunciazione della Vergine, una pala d’altare ritrovata a Narni e tuttora conservata nella Pinacoteca del paese.
L’opera è una grande tempera su tavola, larga 117 centimetri e alta 142, di attribuzione certa, in quanto firmata dallo stesso pittore che, lungo il bordo inferiore del tendaggio di broccato dietro la Vergine, ha inciso in maiuscolo: «OPV[S] BENOTI[I] DE FLORENTI[A]». Questa non è l’unica iscrizione. Ne compare un’altra sul mantello della Vergine: «AV[E] REGINA».
I personaggi della pala, l’Arcangelo Gabriele e Maria, si trovano in un portico, del quale sono visibili due pilastri. La Vergine, con le mani incrociate sul petto, è inginocchiata su un piccolo sgabello, ricalcando il modello dell’Angelico nella terza cella del convento di San Marco a Firenze. Nella parte alta sono ancora parzialmente visibili i raggi di luce, probabilmente completati originariamente dalla figura, oggi perduta, dell’Eterno o della Colomba dello Spirito Santo che dall’alto illuminava la scena. La raffinatezza dell’opera trova riscontro nella cura e nell’eleganza dei dettagli, come ad esempio nelle lumeggiature delle unghie delle mani dei personaggi, nel realismo delle doppie chiavi e nella raffinata decorazione a intarsio del cassone ligneo che si trova alle spalle di Maria.
Danni e restauri
L’opera è molto danneggiata e ha subito diversi interventi di restauro (1901, 1933, 1947, 1952, 1988, 2002). La firma dell’autore era già visibile prima dell’intervento del 1988, anche se questa è la data che è sempre stata accettata per la scoperta dell’iscrizione. Già nel 1959, infatti, Castellani poteva notarla. Forse, però, tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, a causa del cattivo stato di conservazione non era più facilmente leggibile, tanto che il Guardabassi attribuì la tavola a Pierantonio Mezzastris, mentre Eroli la riteneva più genericamente «di scuola umbra».
A restituirla al Gozzoli fu Pératé nel 1907, che la datò al 1450-1452. L’attribuzione al Gozzoli fu accolta anche da Gnoli, il quale successivamente collocò il dipinto intorno al 1449, ritenendola «la più antica opera del maestro fiorentino». Ancora oggi il dipinto viene datato intorno al 1449, in una fase precoce del soggiorno in Umbria del maestro fiorentino che si estese per un periodo di cinque anni. Nel 1449 il pittore è documentato a Orvieto, città non troppo distante da Narni che all’epoca rappresentava un importante centro dello Stato Pontificio, non troppo distante da Roma.
Per quanto riguarda la collocazione, il Guardabassi, alla fine dell’800, la colloca nella chiesa di Santa Maria Maggiore, oggi San Domenico, e scrive: «II Cappella. L’ingresso fu architettato sullo scorcio del XV secolo, alla bellezza delle linee corrispondono sculture ornamentali. Interno. Parete S: Tavola a tempra – l’Annunciazione; opera del Mezzasti». Da Eroli, invece, sappiamo che nel 1898 l’opera già non era più lì: «La seconda Cappella fu denudata de’ suoi ornamenti, come anco de’ quadri che l’abbellivano (…) Non men vaga una piccola tavola, che io vidi quivi appiccata in sulla parete destra dell’altare, avente in sé l’Annunziata, che non dubito attribuire alla scuola umbra; ma i tarli hanno fatto danno, e in breve perirà, se il Municipio, che oggi halla in custodia, non la cura e risana».
Un problema di committenza
Se l’attribuzione dell’opera è certa, incerta è la committenza. La vicinanza di Narni con Orvieto ha sollevato il probabile legame con un’opera raffigurante l’Annunciazione, che era stata richiesta a Benozzo da una «domina Gianna Gregorii» e che era rimasta incompleta per l’insolvenza della committente. Benozzo allora cercò di cedere il dipinto all’Opera del Duomo di Orvieto, offrendosi di ultimare a sue spese il lavoro iniziato. Quelli accettarono l’offerta, dichiarandosi disposti a sostenere il costo dei colori, purché lo stemma di donna Gianna fosse sostituito con quello della Fabbrica del Duomo. Di questo dipinto tuttavia non si conosce né la sorte, né la tecnica esecutiva, ma non è escluso che l’opera fosse quella arrivata poi in modo sconosciuto a Narni.
Un’altra ipotesi è che Benozzo fosse entrato in contatto con i frati domenicani della chiesa di Santa Maria Maggiore di Narni per intermediazione dell’Angelico. In effetti, diversi elementi iconografici, uniti all’originaria collocazione all’interno della chiesa domenicana, portano a rendere più plausibile una committenza narnese. Alcuni dettagli apparentemente solo decorativi, hanno in realtà una funzione fortemente simbolica; se accettiamo la committenza narnese possono fornire importanti indizi non solo sulla committenza stessa, ma anche sulla destinazione dell’opera.
Significati simbolici
Particolare importanza riveste il motivo decorativo del tappeto ai piedi di Maria, costituito da uno stuolo di cani neri, posti tutto intorno alla Madonna, quasi schierati a sua difesa. È probabile che in essi vada vista un’allusione ai frati predicatori secondo un gioco di parole basato sul loro nome latino, Dominicanes; i seguaci di Domenico, infatti, si ritenevano Cani del Signore, appunto Domini canes, in quanto difensori dell’ortodossia cattolica, in particolare per la loro funzione di inquisitori delle eresie. Un altro elemento che rafforza questa tesi è fornito dal colore dei cani, neri con il contorno bianco. Questi sono degli stessi colori del saio indossato dai frati dell’ordine dei Predicatori. Del resto, come già detto, Benozzo era entrato in contatto con i domenicani grazie al suo lungo sodalizio con Beato Angelico, e con questo ordine rimase sempre legato, eseguendo per esso numerosi lavori in diverse città. Un altro elemento a favore della committenza narnese è dato dalla decorazione floreale presente sui pilastri del loggiato che divide l’Arcangelo Gabriele dall’Annunziata. Le foglioline sono chiaramente foglie di edera, raffigurate sia nella forma stilizzata, a cuore, sia in quella più naturalistica. La versione cuoriforme di queste è distintiva della casata degli Eroli e sono presenti nello stemma della nobile famiglia narnese che in questo periodo storico arricchì con molte opere d’arte le chiese cittadine. Dunque quella che sembrava solo una decorazione, probabilmente rappresenta un preciso riferimento alla committenza e pertanto è posto significativamente al centro dell’opera. È molto probabile quindi che il committente sia stato il cardinale Berardo Eroli che, dati i suoi stretti rapporti con alcuni dei maggiori esponenti del mondo politico e religioso del tempo (Niccolò V, i Medici a Firenze, Sant’Antonino Pierozzi, per esempio), potrebbe essere entrato in contatto con l’artista fiorentino e avergli affidato l’opera.
Museo della Città
via Aurelio Saffi, 1 – Narni (TR)
Orari di apertura:
aprile-giugno
dal martedì alla domenica, festivi e prefestivi 10.30-13.00/15.30-18.00
chiuso il lunedì
settembre
tutti i giorni 10.30 – 13.00 / 15.30 – 18.00
ottobre-marzo
venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi 10.30-13.00/15.00-17.30
Chiuso il 25/12. Il 01/01 solo orario pomeridiano.
Telefono: 0744 717117
E-mail: narni@sistemamuseo.it
Bibliografia:
G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, da Cimabue a’ tempi nostri, Firenze, per i tipi di Lorenzo Torrentino, 1550
E. Lunghi, Benozzo Gozzoli a Montefalco, Assisi, Editrice Minerva, 2010
A. Novelli, L. Vignoli, L’arte a Narni tra Medioevo e Illuminismo, Perugia, Era Nuova, 2004
B. Toscano, G. Capitelli, Benozzo Gozzoli allievo a Roma, maestro in Umbria, Silvana Editoriale, 2002










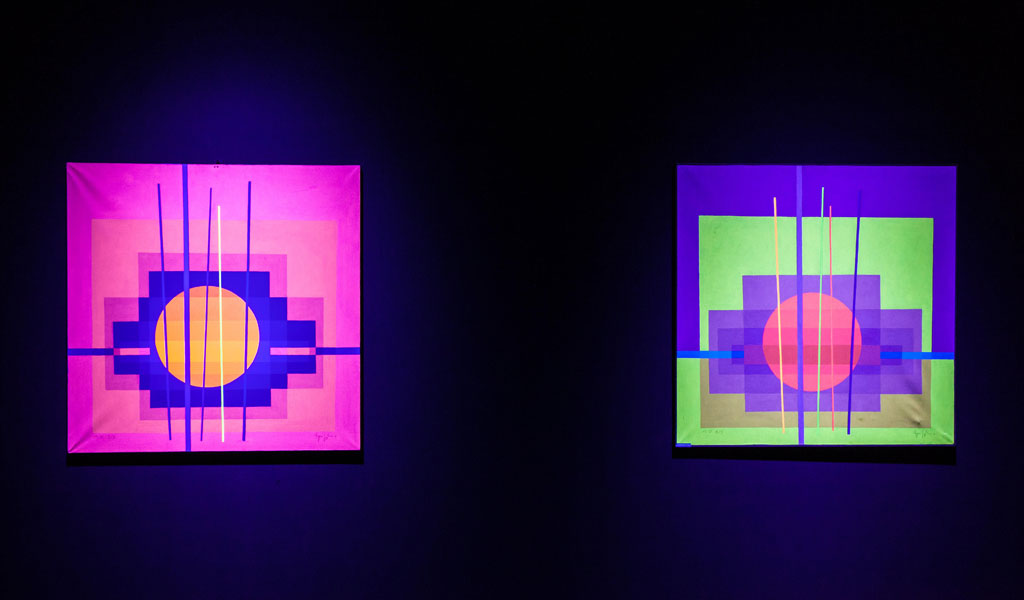





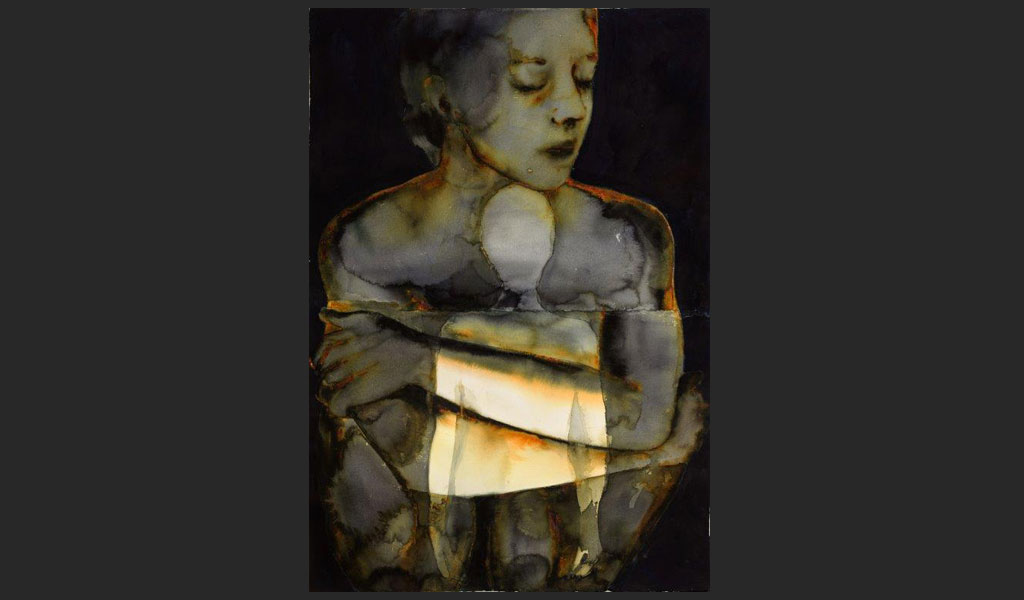
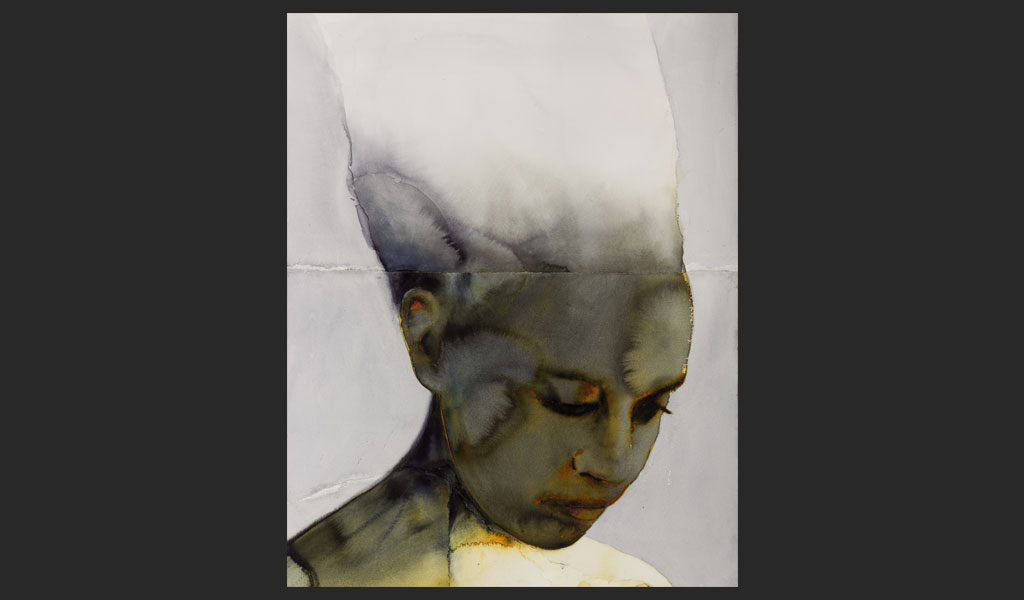

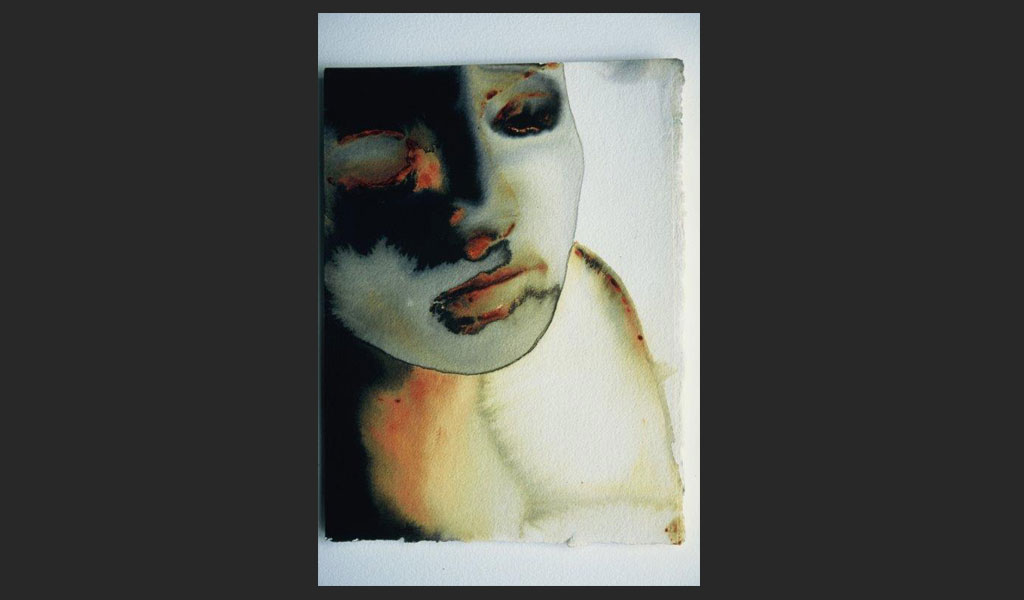







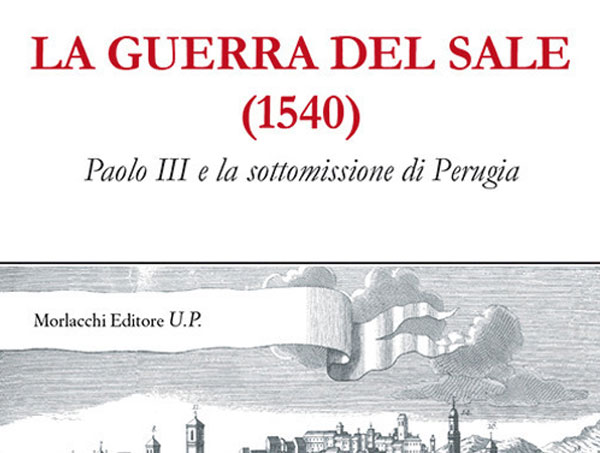
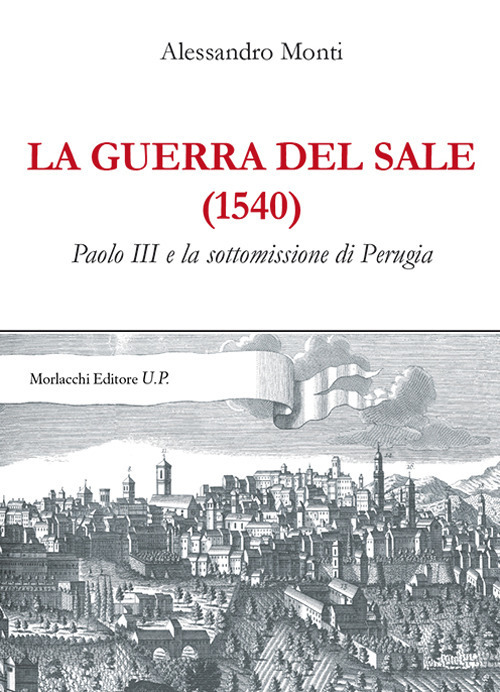 Titolo: La guerra del sale (1540)
Titolo: La guerra del sale (1540)







