I Benedettini e i Francescani hanno avuto un ruolo fondamentale per la flora e la fauna delle nostre montagne, come noi oggi le vediamo. Quale può essere ora il nostro compito?
Ornitologo, faunista, autore di numerose pubblicazioni scientifiche, studioso di storia dell‚Äôambiente dell‚ÄôAppennino, ma anche viaggiatore ed esploratore – ha studiato gli ecosistemi d‚Äôalta quota e dei popoli indigeni montani dai Pirenei e all‚ÄôHimalaya – e attivista del WWF da pi√π di 30 anni, ente per il quale¬Ý ha ricoperto le cariche di consigliere nazionale, delegato regionale, presidente regionale e di sezione: Jacopo Angelini √® tutto questo e molto di pi√π. Con lui abbiamo scattato una fotografia dell‚ÄôAppennino umbro-marchigiano, di come √® cambiato nel corso dei secoli e di come cambier√Ý. Ma soprattutto di come √® stato modellato dai monaci benedettini e francescani.¬Ý¬Ý¬Ý

Prima di tutto, una mia piccola curiosit√Ý. Lei √® faunista, ornitologo, studioso di storia dell‚Äôambiente, esploratore: se si dovesse definire, quale titolo sente pi√π affine? Insomma, chi √® lei?¬Ý
Sono un po’ tutto questo. Avere una preparazione interdisciplinare permette di comprendere il mondo e il nostro territorio a 360 gradi.
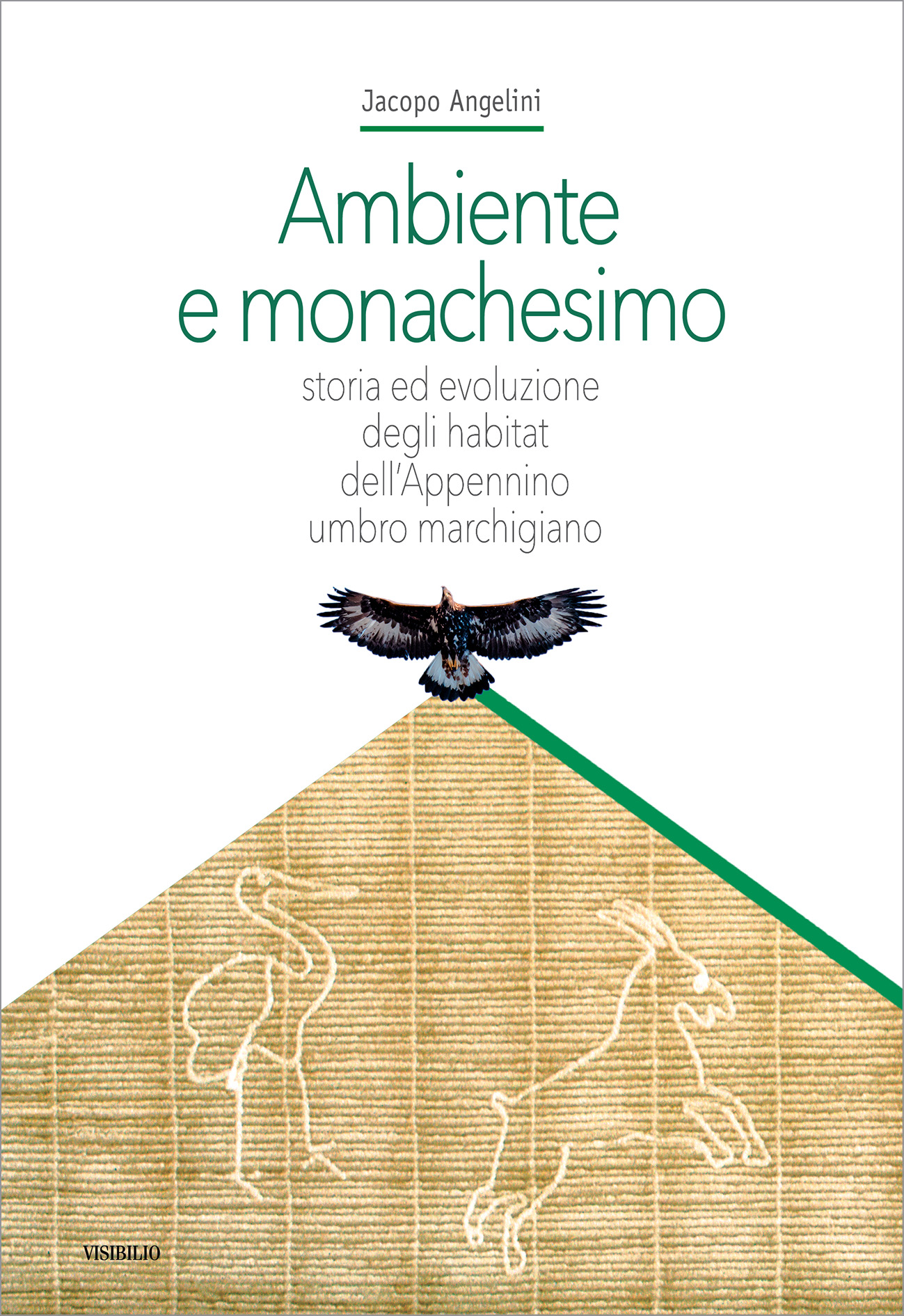
Il suo libro ha come titolo “Ambiente e monachesimo. Storia ed evoluzione degli habitat dell’Appennino umbro-marchigiano”: come si uniscono i due argomenti?
Si uniscono per il fatto che il monachesimo, soprattutto quello benedettino, ma anche poi il francescano, hanno modellato e creato la biodiversit√Ý nell‚ÄôAppennino umbro-marchigiano nel corso dei secoli.
In che modo?
Gestendo le foreste, bonificando le paludi, insegnando alle popolazioni locali come coltivare, cosa coltivare e cosa allevare. Hanno insegnato praticamente tutto, anche la produzione dell‚Äôolivo. Grazie a loro si √® modificato il paesaggio umbro-marchigiano e, tutto quello che oggi vediamo, √® il frutto del loro lavoro, che poi nel corso dei secoli √® stato portato avanti dalle comunanze agrarie e dai Comuni, pur restando presenti le abbazie fino all‚ÄôUnit√Ý d‚ÄôItalia. Penso all‚Äôabbazia di Sassovivo, a quella di Preci o a quella di San Benedetto a Norcia. I monaci hanno avuto un valore immenso: oggi non ce ne rendiamo conto perch√© sono passati secoli, ma se non ci fossero stati loro sarebbe stata un‚Äôenorme foresta senza coltivazioni e avremmo sicuramente meno specie animali.
In pratica hanno dato il via all’habitat che oggi conosciamo…
Esatto. Anche i greggi di pecore, che andavano a transumare dal nostro Appennino fino alla campagna romana, erano di propriet√Ý delle Abbazie; poi sono subentrati i signori locali, ma tutto √® partito da loro. L‚ÄôUmbria √® la terra dei Benedettini e dei Francescani, che avevano due visioni diverse della natura: quella dei Francescani era una visione pi√π spirituale e conservativa, mentre i Benedettini gestivano boschi e foreste, insegnavano a realizzare opere di regimazione delle acque e hanno portato i mulini idraulici.
Com‚Äô√® cambiato l‚ÄôAppennino umbro-marchigiano nel corso dei secoli?¬Ý
√à cambiato in base ai popoli che vi sono passati: penso ai Longobardi che nell‚ÄôAlto Medioevo hanno favorito il bosco, la foresta e all‚Äôallevamento rispetto alla coltivazione, preferita dai Romani; poi, dal 1000 al 1300 – siamo nel Basso Medioevo – il clima √® diventato pi√π caldo e piovoso ha reso possibili insediamenti d‚Äôaltura: penso a Castelluccio di Norcia. Nel Rinascimento sono le citt√Ý comunali a gestire il territorio e il paesaggio, poi fino al 1800 si vive con la mezzadria sulle montagne e in campagna, mentre negli ultimi 50 anni l‚Äôambiente √® cambiato, sono ritornate le foreste come nell‚ÄôAlto Medioevo perch√© l‚Äôuomo ha lasciato la montagna per scendere a fondo valle e quindi la natura si √® riappropriata dei suoi spazi.

Come accennava, anche all’epoca c’era il cambiamento climatico?
Certo, ma logicamente aveva una velocit√Ý inferiore: noi in vent‚Äôanni vediamo quello che i Romani vedevano nei 300 anni. E poi ovviamente la Terra era abitata da meno persone.
In futuro cosa dovremmo fare per mantenere questi territori?
Dovremmo prendere esempio dai Benedettini: le campagne e le colline sono tutte arate e coltivate, ma dopo la raccolta dei cereali, fino all’anno dopo, questi campi restano senza nessuna trattenuta da parte dell’acqua, ecco perché avvengono frane e inondazioni, quindi dovremmo cercare di realizzare opere di adattamento e di mitigazione.
Parliamo di fauna: quella dell’Appennino in che condizioni è?
√à cambiata. Sono presenti tante specie legate alla foresta come il cinghiale – che √® un po‚Äô dappertutto, anche in citt√Ý ‚Äì e il capriolo, mentre specie legate agli ambienti coltivati dall‚Äôuomo, come la starna e la lepre, sono diventate molto rare. Poi ci sono i lupi che sono avvantaggiati della presenza di ungulati e vivono in ambienti anche urbani: a loro basta poco, un bosco fluviale; li troviamo anche nelle citt√Ý perch√© seguono i caprioli e i cinghiali e mangiano le nutrie.

Si è occupato di “monitoraggio attivo”: quanto è utile per salvare il nostro ambiente?
Il monitoraggio è fondamentale. Senza monitoraggio – da parte delle Regioni e degli enti Рnon ci sarebbero i dati e non si potrebbe intervenire per mettere in campo scelte politiche e gestionali. È una metodologia importante da applicare. Può essere fatto anche dai cittadini: c’è proprio una branca della scienza che si chiama citizen science in cui le persone comuni forniscono i dati agli enti, è una pratica molto utile per tutti.
Lei √® un viaggiatore ed esploratore: c‚Äô√® un percorso che consiglierebbe per scoprire le bellezze naturalistiche dell‚ÄôUmbria?¬Ý
Il parco del Monte Subasio offre posti bellissimi da scoprire e passeggiate facili; un’altra zona molto bella è quella di Colfiorito, o quella dei Monti Martani Рpoco conosciuta e particolare – senza dimenticare il Parco dei Sibillini e la Valnerina che è fantastica: stare lì permette di tornare indietro nel Medioevo.
Agnese Priorelli
Ultimi post di Agnese Priorelli (vedi tutti)
- Elisa Brufani: ¬´Oggi si fotografa tutto, si √® persa la sacralit√Ý dello scatto. L‚ÄôAI √® entrata nel nostro lavoro¬ª - Luglio 10, 2025
- Orvieto, location per le riprese del film con Mastandrea, Riondino e Valentina Lodovini - Giugno 24, 2025
- Trabalza e Jin, quando la fotografia fonde alla perfezione mondi e stili differenti - Giugno 19, 2025



